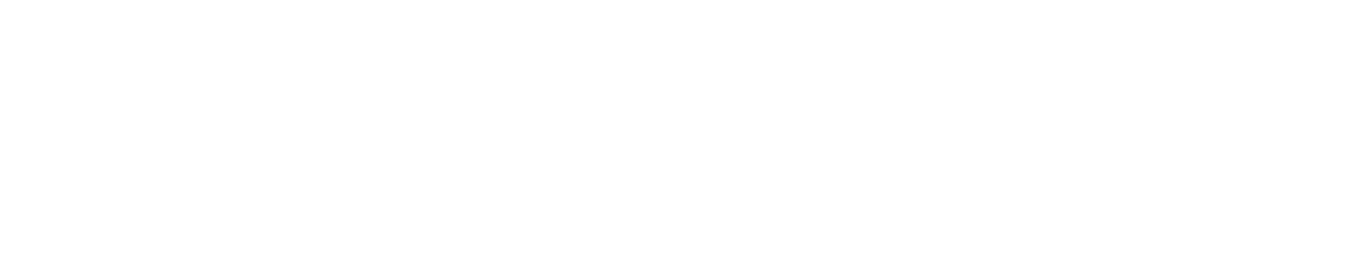Dal 23 settembre 2025 le sale monumentali di Castel Sant’Angelo ospitano la mostra Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo, promossa e realizzata dall’istituto del Ministero della Cultura Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma – diretto ad interim da Luca Mercuri – in occasione del centenario dell’istituzione del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, avvenuta con Regio Decreto del 4 maggio 1925.
Si tratta di una tappa fondamentale nella lunga e complessa storia di questo straordinario edificio, nato come mausoleo imperiale e divenuto, nei secoli, fortificazione, residenza papale, carcere e caserma. La nascita del museo segna il momento in cui il monumento viene restituito a una dimensione prettamente culturale: una istituzione pubblica che, da allora come ancora oggi, si impegna a valorizzare l’edificio e le collezioni che custodisce, rivolgendosi a tutti i pubblici, nazionali e internazionali.
Le origini di questo percorso affondano le radici in un altro momento simbolico: l’Esposizione del 1911, allestita proprio a Castel Sant’Angelo in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia. Fu allora che il Castello venne trasformato in spazio espositivo, attraverso una mostra retrospettiva sull’arte italiana dalle origini al presente, che coniugava archeologia, arti figurative, arti decorative, ambientazioni storiche e percorsi tematici. Un’operazione culturale e simbolica che, proprio per la sua ambizione narrativa e sperimentale, contribuì in modo determinante alla riconfigurazione del monumento nel suo nuovo ruolo.
La mostra Castel Sant’Angelo 1911–1925. L’alba di un museo si ispira a quello straordinario esperimento, rievocandone in chiave contemporanea atmosfere e suggestioni.
Il progetto, ideato dal Direttore ad interim del Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, Luca Mercuri, si avvale del contributo di un comitato scientifico composto da Matilde Amaturo, Luigi Gallo, Ilaria Miarelli Mariani e Mario Scalini.
“Questa mostra – commenta Luca Mercuri – rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire un momento fondativo della storia del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo e, insieme, per riflettere sul ruolo civile del patrimonio culturale nella costruzione di una memoria condivisa. Concepita come un omaggio all’Esposizione del 1911, l’iniziativa restituisce, in chiave critica e contemporanea, lo spirito sperimentale di quella straordinaria impresa espositiva, capace di coniugare rigore scientifico e impatto narrativo, memoria e innovazione. Il percorso mette in dialogo opere provenienti da importanti musei italiani con materiali straordinari custoditi nei depositi del Castello, alcuni dei quali restaurati per l’occasione e non esposti al pubblico da decenni. Si tratta, dunque, non solo di una mostra, ma di una vera e propria operazione culturale che, grazie anche a prestiti d’eccellenza, restituisce centralità alla funzione pubblica del museo: custodire e al tempo stesso condividere il patrimonio, recuperare il passato per guardare al futuro. Un progetto che parla alla città e a tutti i pubblici, e che rinnova il legame profondo tra Castel Sant’Angelo, la sua storia e la sua vocazione culturale.”
L’allestimento si snoda in alcuni degli ambienti più rappresentativi del Castello – dalle Sale di Clemente VIII, alla Sala della Giustizia, fino all’appartamento di Clemente VII e alla magnifica Sala di Apollo. Si comincia con gli acquerelli di Ettore Roesler Franz, provenienti dal Museo di Roma: vedute raffinate che documentano una Roma che stava sparendo sotto le trasformazioni urbanistiche richieste dal suo nuovo ruolo di Capitale del Regno. Spicca poi lo straordinario dipinto di Umberto Prencipe con veduta di Roma nel Quattrocento, dal Museo Boncompagni Ludovisi, concepito proprio per la mostra del 1911: le sue dimensioni monumentali, il chiarore dell’alba che sta per sorgere, il respiro della composizione hanno ispirato il titolo della mostra odierna, L’alba di un museo.
Dalla collezione Gorga, anch’essa protagonista della mostra del 1911, emergono certamente i celebri strumenti musicali ma anche oggetti archeologici come una suggestiva stele tardoantica raffigurante un pretoriano. Quest’ultima, insieme alle eccezionali lastre romaniche scolpite, restaurate per l’occasione e restituite dai depositi del Museo delle Civiltà, omaggia la sezione dedicata nel 1911 alla lavorazione del marmo. Notevole è poi la scultura in gesso colorato di Giovanni Prini, con l’incontro tra il pontefice Eugenio IV e il castellano Antonio da Rido, appartenente alla sezione dedicata nel 1911 al racconto dei costumi e degli abiti storici.
Spicca poi l’Elia nel deserto dagli Uffizi, opera di Daniele da Volterra, allievo di Michelangelo, che rende omaggio alla sezione “michelangiolesca” del 1911.
Dalla Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Barberini proviene la Veduta del Tevere a Castel Sant’Angelo del Vanvitelli, immagine storica che lega il monumento al suo paesaggio urbano, mentre dall’Accademia di San Luca arriva una scultura in terracotta del Giambologna, allegoria di fiume, testimonianza del collezionismo accademico romano.
Una sezione specifica è dedicata a Bartolomeo Pinelli, artista che nella Roma dell’Ottocento seppe rappresentare con straordinaria forza visiva i mestieri popolari e le scene di vita quotidiana: le opere esposte si inseriscono in un filone che, nella mostra del 1911, intendeva valorizzare le espressioni dell’arte e della tradizione popolare, documentando il volto più autentico della città.
Un grande spazio è dedicato alle armi e armature storiche, in dialogo ideale con la sezione “uomini in arme” del 1911. Accanto a prestiti prestigiosi – come due celate provenienti dal Bargello di Firenze – si segnalano numerose opere restaurate per l’occasione dai depositi del Castello: tra queste, una straordinaria armatura medicea della seconda metà del XVI secolo. L’allestimento restituisce con efficacia la forza espressiva di questi oggetti, che dialogano idealmente con il ritratto di Alfonso I d’Este di Battista Dossi, proveniente dalla Galleria Estense di Modena, figura nota anche per la sua passione per l’artiglieria.
Una sezione importante è dedicata a Giovan Battista Piranesi. Le celebri Carceri d’invenzione, realizzate come metafora delle prigioni dell’anima, prendono idealmente ispirazione proprio dalle prigioni storiche di Castel Sant’Angelo. Le stampe, tirate appositamente dalla Regia Calcografia per la mostra del 1911, sono oggi esposte in un allestimento che ne sottolinea il legame con la funzione carceraria del monumento, affiancate da oggetti che ne evocano la storia.
Il percorso prosegue con una sezione archeologica, dove incisioni di Piranesi dedicate ai monumenti antichi – tra cui Castel Sant’Angelo – anch’esse stampate dalla Regia Calcografia nel 1911 e conservate nei depositi del Museo, ma mai esposte negli ultimi decenni, dialogano con reperti antichi. Tra questi, materiali archeologici dello stesso Castel Sant’Angelo: spiccano le puntazze con tracce di legno carbonizzato ritrovate presso Ponte Sant’Angelo, resti degli antichi pali di fondazione ancora perfettamente leggibili, e alcuni bipedali in marmo bollati provenienti dal Mausoleo.
La mostra si conclude nella magnifica Sala di Apollo, dove è stato riposizionato il grande plastico di Castel Sant’Angelo realizzato nel 1911, che osserva idealmente i busti marmorei di Adriano e Antonino Pio, legati alla fondazione e alla storia del Mausoleo. In un vano laterale, come un controcanto intimo, trova spazio l’angelo in legno dorato del Bracci, scelto come immagine simbolo dell’allestimento.
Alcune immagini storiche sono presentate in teca come preziosi documenti originali, capaci di restituire lo sguardo del tempo su quell’evento straordinario. Altre fotografie, riprodotte in grande formato lungo il percorso espositivo, creano un’esperienza immersiva: mettono in dialogo oggetti presenti nella mostra del 1911 con quelli oggi nuovamente esposti o con opere che ne rievocano lo spirito. Si segnala l’immagine monumentale dell’inaugurazione, che restituisce l’atmosfera istituzionale e festosa della giornata, alla presenza dei sovrani.
Le fotografie dialogano anche con altri materiali originali del 1911: il manifesto storico della mostra, esposto in originale, la guida originale dell’Esposizione ma anche una sua copia anastatica sfogliabile, che il pubblico può liberamente consultare. La presenza infine, della guida della mostra attuale, disponibile nel bookshop del Castello, suggerisce un gioco di rimandi tra passato e presente.
La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio 2026 ed è inclusa nel costo del biglietto ordinario di accesso al Castello.

Nell’ordine, da sinistra:
Ettore Roesler Franz (Roma, 1845 – 1907), ciclo Roma Pittoresca: memoria di un’era che passa (Seconda Serie), Prati di Castello oggi sul luogo sorge il Palazzo di Giustizia, 1886, acquerello su carta, Roma, Museo di Roma in Trastevere, inv. MR-105
Umberto Prencipe (Napoli, 1879 – Roma, 1962), Grande Veduta di Roma, 1910, olio su tela, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, inv. 9111 (Deposito Museo Boncompagni Ludovisi)
Sala_Le Mostre Retrospettive di Castel Sant’Angelo
Battista di Niccolò Luteri, detto Battista Dossi (San Giovanni del Dosso, ante 1500 – Ferrara, 1548), Ritratto del duca Alfonso I d’Este, ca. 1534-1536, olio su tela, Modena, Galleria Estense, inv. R.C.G.E. 450
Daniele Ricciarelli, detto Daniele da Volterra (Volterra, 1509 – Roma, 1566), Il Profeta Elia nel deserto, 1543-1547, olio su tela, Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1890 n. 10744
Rilievo raffigurante leoni affrontati, XI-XII secolo, marmo, Roma, Museo delle Civiltà, inv. 2256
Corsaletto composito e zuccotto aguzzo della cerchia di Alessandro Farnese, seconda metà del XVI secolo, inv. CSA VI/6 e 1455
Sala_Piranesi e le Carceri, nei labirinti dell’inconscio
Giuseppe Graziosi (Savignano sul Panaro, 1879 – Firenze, 1942), Plastico raffigurante il Mausoleo di Adriano, 1901, legno, gesso e stucco dipinti, Roma, Castel Sant’Angelo, inv. CSA IV/170
Pietro Bracci (Roma, 1700 – 1773), San Michele Arcangelo, 1736, legno scolpito e dorato a foglia, Roma, Castel Sant’Angelo, inv. CSA IV/108