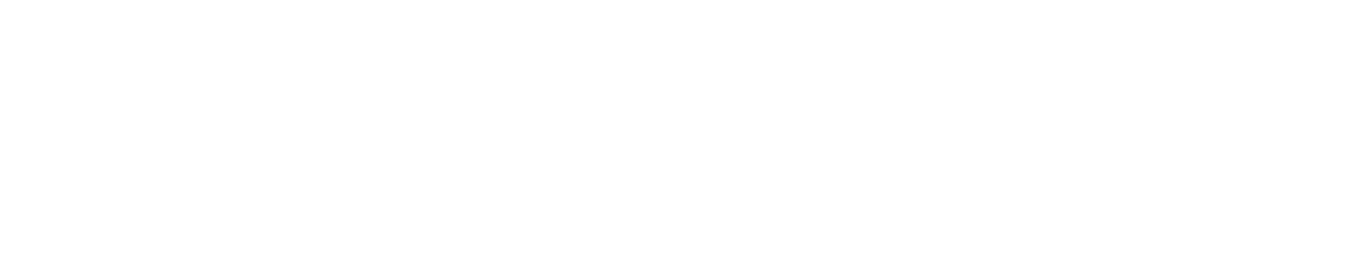Restauro di ‘Dopo la battaglia’ presso la Galleria Spada

Jacques Courtois (Saint-Hippolyte 1621 – Roma 1676) Dopo la battaglia 1650 circa Olio su tela Restauro 2022 Il dipinto fa parte di una coppia di Battaglie del più noto generista del Seicento, Jacques Courtois detto il Borgognone delle Battaglie. Come il suo pendant, presentava una generale opacizzazione ai limiti dell’illegibilità dovuta all’alterazione delle vernici protettive stese a più riprese nel corso del tempo. Le due tele, racchiuse in cornici intagliate e dorate di altissima manifattura barocca romana, sono state pienamente recuperate, evidenziando colori chiari e brillanti nel cielo, ancora solcato dai fumi della battaglia, e moltissimi particolari sinora illegibili. L’intervento sulle cornici, limitato ad operazioni sanitarie e di semplice pulitura, ha scoperto una foglia d’oro ricca, spessa e ben conservata, con effetti di straordinaria lucentezza.
Restauro di ‘Sacra Famiglia con San Giovannino’ presso la Galleria Spada

Valentin de Boulogne (Coulommiers 1591 – Roma 1632) Sacra Famiglia con San Giovannino Olio su tela Restauro 2022 Superba espressione dell’arte di Valentin de Boulogne, l’opera è concordemente riferita alla produzione matura del pittore ed è generalmente collocata in un torno di tempo che sta tra il 1627 e il 1630. L’accurata pulitura ha permesso di restituire luminosità agli incarnati, volume ai sontuosi panneggi azzurri liberati dai ripetuti strati di ridipinture e credibilità alla figura di san Giovanni Battista in controluce. Valentin ha ormai rifuso ogni nuovo spunto appreso a Roma, da Manfredi a Vouet, e la canestra offerta da San Giovanni è una sorta di omaggio non solo al Bambino, ma anche al mondo nuovo della pittura seicentesca.
Restauro di ‘Tre teste’ presso la Galleria Spada

Francesco Mazzola, detto il Parmigianino (Parma 1503 – Casalmaggiore 1540) Tre teste Dipinto murale staccato Restauro 2021 Un intervento conservativo di estrema importanza per ampliare le conoscenze su un’opera cinquecentesca di notevole complessità; un restauro che ha implicato svariati confronti tra gli specialisti di Parmigianino, nonché attente analisi con il grande restauratore che curò, nel lontano 1968, l’ultimo lavoro sul dipinto. Lo studio del pezzo ha, inoltre, portato ad individuarne la provenienza dalla celebre collezione romana dei marchesi Giustiniani, presso i quali gli Spada lo acquistarono nel corso dell’Ottocento.
Restauro di ‘Tavoli da muro barocchi’ presso la Galleria Spada

Maestranze romane della fine del sec. XVII Tavoli da muro barocchi Legno scolpito, intagliato e dorato; piani in marmi vari. Restauro 2020 – 2023 Ambizioso e articolato progetto sulle diverse serie di due e di quattro tavoli da muro barocchi che arricchiscono gli ambienti della Galleria Spada dalla fine del Seicento. Manufatti di altissimo artigianato romano, i tavoli hanno strutture in legno finemente lavorato, sormontato da pesanti piani in verde antico e in marmo rosso di Sicilia che, a loro volta, sostengono le sculture della collezione archeologica. Il lavoro, di conseguenza, si è configurato in primo luogo come verifica della sicurezza strutturale degli arredi; il loro smontaggio ha implicato operazioni specialistiche delicate e impegnative e soluzioni diverse per garantire l’adeguata presentazione del museo nel corso di questo importante “cantiere aperto”. Ne sono scaturiti, oltre a moltissimi dati costruttivi e informazioni per lo studio degli eccezionali arredi, anche risultati notevolissimi relativamente al recupero delle dorature, liberate da strati di gommalacca e depositi che ne alteravano completamente la cromia.
Restauro di ‘Pannello di bussola’ presso la Galleria Spada

Maestranze romane del sec. XIX Pannello di bussola Sec. XIX Vetrata legata a piombo Rimossa e sostituita transitoriamente con una lastra di vetro soffiato al fine di non pregiudicare l’estetica della bussola da cui si accede alla Galleria, la vetrata a piombo è stata sottoposta ad operazioni di pulitura e consolidamento estremamente necessarie: dall’Ottocento essa fa parte della porta che costituisce l’abituale accesso delle Sale espositive. Perfettamente manutenuto da maestranze altamente specializzate, il pannello in vetro piombato è la dimostrazione di come anche la cura dei dettagli di svariato tipo concorra all’armonia e alla corretta conservazione dell’insieme del museo.
Restauro di ‘Pendola da tavolo’ presso la Galleria Spada

Raffaele Fiorelli (attivo metà sec. XVIII – inizi XIX) Pendola da tavolo Sec. XVIII Marmo, bronzo, smalto; movimento tipo Courvoisier. Galleria Spada La pendola a portico in marmo bianco e bronzo dorato con figura della dea Minerva fu acquistata nel 1793 dal principe Giuseppe Spada direttamente dall’orologiaio Raffaele Fiorelli, cui si devono importanti orologi monumentali romani, come quello sulla Torre del Campidoglio e quelli realizzati per San Pietro in Vaticano. L’intervento, eseguito da un espertissimo restauratore di meccanismi antichi, ha rifunzionalizzato la pendola, la cui suoneria è predisposta per suonare “all’italiana”, ovvero scandendo le battute delle ore di sei in sei. Originariamente l’orologio era predisposto a liberare, allo scoccare di ogni ora, l’organo a canne posto all’interno della base in legno e bronzo su cui poggia l’orologio stesso.
Restauro di ‘L’Amor Sacro atterra l’Amor Profano’ presso la Galleria Spada

Galleria Spada François Duquesnoy (Bruxelles, 12 gennaio 1597 – Livorno, 18 luglio 1643) L’Amor Sacro atterra l’Amor Profano Stucco Restauro 2019 Eseguito in occasione della ricollocazione dell’opera nella prima Sala della Galleria – dove il rilievo si accorda con altre importanti manifestazioni del classicismo seicentesco –, il restauro ha permesso di eseguire anche un controllo puntuale della stabilità dell’antico sistema di ancoraggio alla cornice, al fine di garantire solidità e sicurezza al pezzo. Sono stati condotti approfondimenti sulla tecnica esecutiva, che hanno evidenziato una lavorazione condotta spatolando il materiale costitutivo con inserimento nell’impasto di fibre legnose a garanzia della tenuta. Ripristinato un adeguato sistema di sostegno, l’opera è stata liberata dallo strato di polvere sedimentata e da vecchi ritocchi, riguadagnando la cromia originale ed evidenziando la qualità del rilievo.
LA BELLEZZA DELL’INTELLIGENZA – Restauro conservativo di 20 abiti della collezione Palma Bucarelli. Museo Boncompagni Ludovisi

Alcuni abiti del guardaroba di Palma Bucarelli donati al Museo Boncompagni Ludovisi nel 1996 e nel 2010 sono stati recentemente sottoposti a un accurato e attento restauro che ha permesso la pulitura e il consolidamento dei tessuti e degli elementi decorativi. Gli abiti e i gioielli indossati da Palma Bucarelli nelle diverse occasioni delineano la sua identità di donna carismatica e all’avanguardia e testimoniano lo stretto legame fra arte, moda e innovazione vissute sempre alla ribalta dell’interesse mediatico. I suddetti abiti rappresentano un’importante testimonianza storica e artistica legata alla straordinaria figura di Palma Bucarelli, documentando in larga parte la produzione tessile italiana dagli anni ’40 agli anni ’70. Il progetto di restauro, scaturito in occasione di un nuovo allestimento di parte della collezione, ha visto l’esecuzione di molteplici interventi al fine di conservare e tramandare nel miglior modo possibile questo patrimonio tessile. La tipologia dei manufatti presenti all’interno della collezione è molto vasta e differenziata in quanto a materiali e tecniche di realizzazione; la specificità degli interventi di restauro è perciò dipesa a volte dalle caratteristiche del tessuto, altre dalla foggia o dagli elementi sartoriali, altre ancora dalle decorazioni. Diversi manufatti sono stati oggetto di un accurato intervento di restauro perché in cattivo stato di conservazione, altri hanno necessitato di interventi conservativi minori. Ogni intervento è stato perciò deciso in base ad una valutazione complessiva che ha tenuto conto di tutti gli elementi caratteristici del singolo manufatto. Dopo una prima fase preliminare in cui si sono raccolte tutte le informazioni riguardanti le caratteristiche materiche, di confezione, di conservazione etc., sono state realizzate delle schede dei singoli abiti sulle quali si sono annotate le specifiche caratteristiche, lo stato di degrado, la sua ampiezza, le sue cause e i singoli interventi da effettuare. L’intervento di restauro è consistito, caso per caso, nello smontaggio parziale della confezione per poter procedere alle operazioni di consolidamento. L’allestimento degli abiti restaurati è avvenuto posizionando ogni singolo abito su dei manichini realizzati ad hoc, talvolta modificati attraverso l’inserimento di imbottiture e riempitivi al fine di accogliere i volumi degli abiti senza creare stress meccanici. Così in una nuova veste sono stati allestiti nel percorso permanente del museo modelli da giorno, pomeriggio, cocktail, sera databili tra gli anni Quaranta e gli anni Settanta del Novecento che recano le firme di note sartorie romane e napoletane oggi scomparse. Il restauro conservativo è stato affidato alla dott. ssa Nicoletta Vicenzi.
RESTAURO DI UN ARAZZO DI MANIFATTURA FIAMMINGA (XVII SEC.) per il Progetto ‘Sleeping Beauty’ – Museo Boncompagni Ludovisi

L’intervento di restauro è stato finanziato con il “Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero” (anno 2020) ed è stato affidato alla restauratrice, dott. ssa Nicoletta Vicenzi. L’arazzo in lana e seta di manifattura fiamminga (metà sec XVII) con scene boschive era stato per un lungo periodo “nascosto” da pesanti teli che servivano da sfondo ad un gruppo di dodici arazzi contemporanei appartenenti alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Al momento dell’intervento di restauro l’arazzo presentava uno stato di conservazione mediocre. Consistenti depositi di polvere risultavano presenti su tutta la superfice, intrappolati nel fitto intreccio delle fibre insieme a lacune di varia entità, perdita di trame, tagli, importanti macchie di muffa. Anche la fodera stessa era stata interessata da depositi di polvere, deformazioni e lacune provocate da attacchi biologici. In ultimo l’erroneo sistema di ancoraggio a parete mediante tubi metallici interni alle fodere aveva creato delle fortissime deformazioni al tessuto. L’arazzo non “cadeva” in modo naturale come avrebbe dovuto fare per sua peculiarità. L’intervento di restauro sull’arazzo ha avuto pertanto una duplice finalità: da un lato ha ripristinato la solidità, restituendo al manufatto l’autosufficienza che gli ha consentito di essere maneggiato ed esposto con sicurezza; dall’altro ha consentito il massimo recupero dell’immagine compatibile con il suo stato attuale.